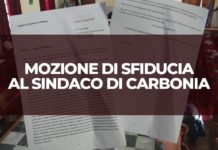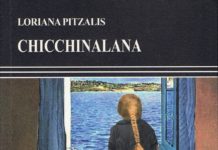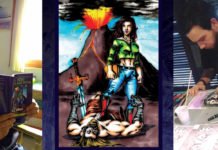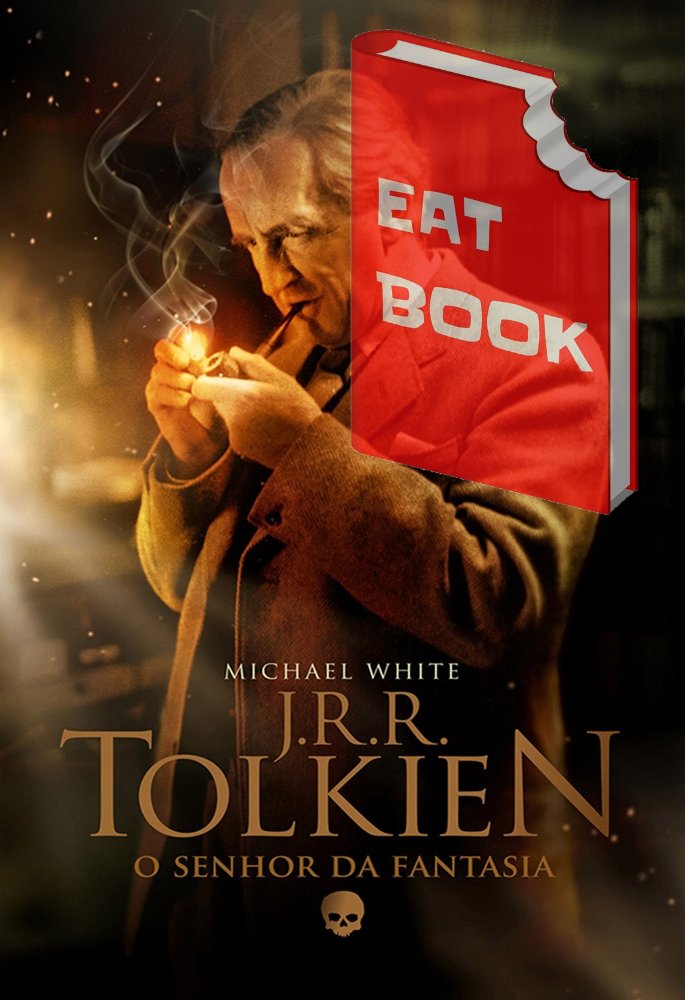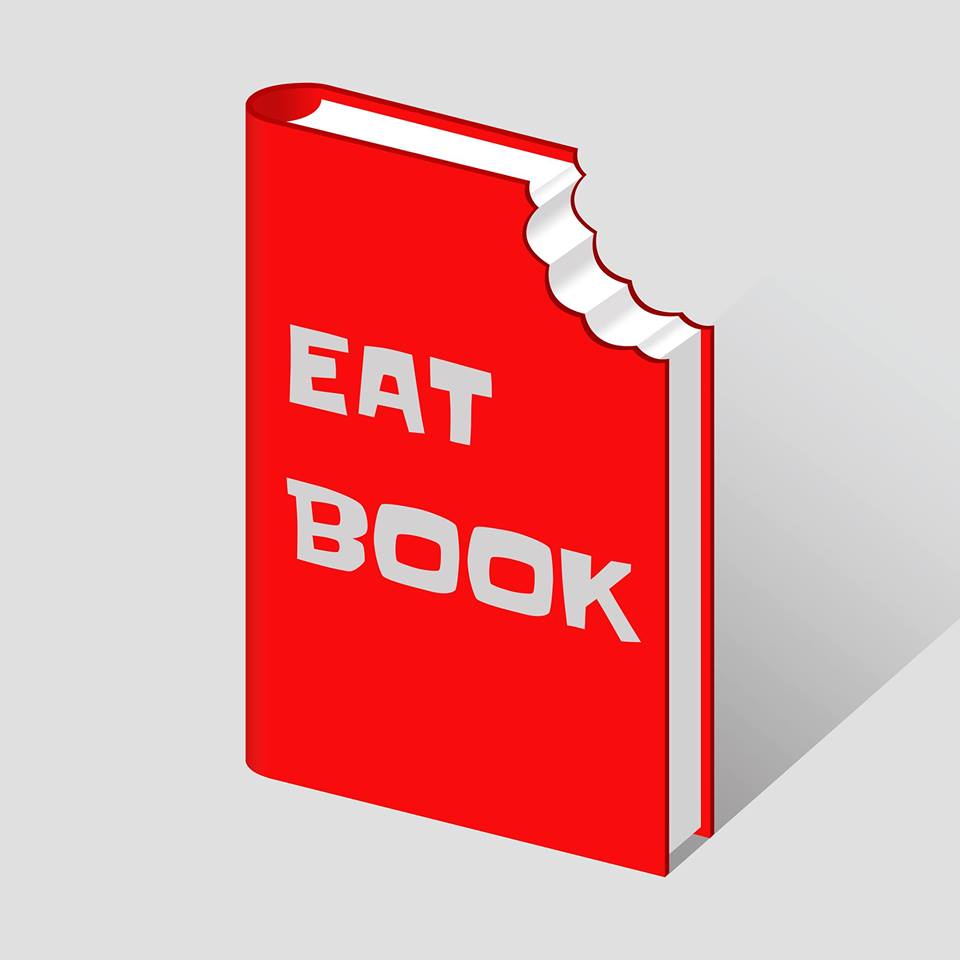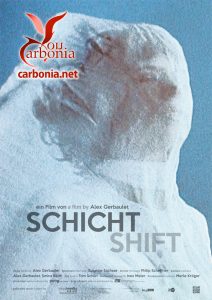Nella seconda giornata del Carbonia Film Festival, sono stati presentati quattro cortometraggi e due lungometraggi in concorso. In questo articolo potete trovarli recensiti da Carbonia.net nell’ordine di proiezione.
CORTOMETRAGGI:
 RECENSIONE – I DON’T WANT TO SLEEP WITH YOU I JUST WANT TO MAKE YOU HARD
RECENSIONE – I DON’T WANT TO SLEEP WITH YOU I JUST WANT TO MAKE YOU HARD
Regia di Momoko Seto (Francia, 2016, 30′)
I don’t want to sleep with you I just want to make you hard è un titolo lungo che descrive bene i contenuti del corto, che si protrae anche nella durata, rientrando di precisione nei tempi massimi previsti per i cortometraggi.
Bisogna tuttavia dire da subito che il film scorre rapidamente, trasmettendo un mix di strane sensazioni che catturano l’attenzione. Il corto racconta alcuni incontri nei Kyabakura, un particolare genere di locale giapponese frequentato da uomini ai quali viene offerta, in cambio di denaro, la possibilità di entrare in relazione in modo piuttosto intimo con ragazze tendenzialmente giovani, dovendo tuttavia rispettare alcune norme molto rigide, tra le quali spicca particolarmente il divieto del contatto fisico.
Queste regole molto spesso non vengono rispettate e la tensione causata dal divieto emerge chiaramente in un anomalo contesto. In effetti è davvero complicato, da un punto di vista esterno, trovare un’interpretazione per le dinamiche che vengono a crearsi in questi luoghi.
Il punto di forza del corto va ricercato anche in quest’impossibilità, ovvero nel fatto che il lavoro di Momoko Seto ci permette di conoscere una realtà così tanto diversa dalla nostra da risultare tendenzialmente indecifrabile. Sicuramente alla base di questo documentario c’è l’intenzione di evidenziare l’alienazione della società che viene osservata: da un lato possiamo vedere uomini stressati e impacciati che tentano col denaro di acquisire controllo nei confronti dell’altro sesso, mentre dall’altro lato ragazze che, attratte dalla possibilità di un alto compenso, subiscono enormi manipolazioni emotive. Tuttavia ciò che accade davvero tra cliente e hostess è qualcosa di molto complesso che tende all’inspiegabilità e lo stesso sguardo della regista sembra vacillare tra biasimo e divertita osservazione.
Nella fenomenologia di questo strano rapporto troviamo la ricerca dell’eros attraverso l’atto stesso del far ridere. Troviamo una bizzarra pudicizia in conflitto con tutta una serie di gesti, desideri e scambi che lasciano intravedere una costante tensione, anche nelle situazioni di apparente intesa e rilassamento. Ma troviamo soprattutto, ed è la cosa che forse possiamo comprendere maggiormente rispetto a ciò che accade nei Kyabakura, la ricerca costante della carica erotica sprigionata dalla scoperta dell’altro. Tutto questo con un più o meno ovattato sottofondo di repressione.
Tecnicamente il cortometraggio è ben girato, il montaggio è ottimo – a parte qualche stacco fastidioso – e può vantare una bella fotografia. Peccato per l’ingiustificabile uso dello zoom in diverse riprese.
Nel complesso I don’t want to sleep with you I just want to make you hard è un lavoro di qualità, che riesce a essere critico nel guardare alla società ma al contempo affascinante e interessante.
Regia di Grzegorz Szczepaniak (Polonia, 2015, 29′)
Snails (lumache) si presenta immediatamente come un lavoro curioso. Un cortometraggio che parla delle lumache attraverso il successo del “mercato della lumaca” e del conseguente desiderio di due amici di cimentarsi in questo settore aprendo una propria azienda agricola.
Il risultato è semplicemente geniale e il documentario diventa brillante narrazione attraverso un uso intelligente e divertente di immagini e riprese delle chiocciole e dei loro “sfruttatori”: lumache letteralmente ovunque vengono allevate, inseguite, mangiate, cantate. Vengono fatte persino gareggiare con tanto di numeretto da maratoneta.
In Snails possiamo addirittura trovare alcune scene “passionali”, nelle quali viene mostrata la copula della lumaca. A fare da letto d’amore una foglia di lattuga in un ambiente caratterizzato dalla luce rossa e sensuale.
Il cortometraggio è impeccabile anche tecnicamente: fotografia, movimenti di macchina, montaggio, tutto sembra al proprio posto. E merita un elogio anche la realizzazione e la collocazione dei capitoli animati usati come intermezzo.
E nel caso in cui sorga il dubbio che lo sfruttamento di queste piccole creature possa risultare di cattivo gusto in un film così tanto divertente, la risposta è che il lavoro di Grzegorz Szczepaniak porta in realtà a simpatizzare con le protagoniste, tanto che viene voglia di rispettare ogni lumaca e volerle bene.
Memorabile il dialogo tra Andrzej e Konrad: “come può un allevatore di lumache morire da guerriero?” la risposta è semplicemente “può essere entrambi”.
Regia di Alex Gerbaulet (Germania, 2015, 28′)
Schicht significa turno. Ed è un’opera molto difficile, che basa tecnicamente il proprio significato sul ritmo e sullo scorrere del tempo e delle immagini, riflettendo nel linguaggio cinematografico l’esistenza a Salzgitter, la città della regista. Questo luogo, questa sorta di andamento e di reazione agli accadimenti della vita, può essere ben compreso da chiunque viva in una città industriale destinata progressivamente al declino.
Il ritratto della famiglia della regista viene raccontato meccanicamente attraverso lente concatenazioni causali.
Numerose sequenze fotografiche intervallano il video, caratterizzato da un uomo che corre con il proprio cane – come una traccia di vita testimone di un passato che poi è di fatto ancora presente, pur non essendolo.
Ritmi scanditi lentamente, voluti tagli netti e vuoti narrativi, esprimono la disumanizzazione portata dal declino del lavoro. Lavoro e declino possono essere le due facce di una stessa, pesante, medaglia.
Immagini piacevoli vengono bruscamente interrotte dai problemi e dalla malattia. In effetti a contribuire al ritmo del cortometraggio sono i rumori delle strade e delle industrie, ma soprattutto il diario della moglie del signor Rudolf Gerbaulet, attraverso il quale possiamo seguire la scomparsa di Doris a causa della sclerosi multipla. Il significato del film va cercato nel lento percorso che porta alla morte della madre della regista.
Non è un film per tutti poiché può essere impegnativo da seguire e complicato da comprendere. Inoltre rientra in una delicata categoria di proposta cinematografica, ovvero quella che attira principalmente l’interesse di chi vive personalmente quella dimensione, trasmettendogli un ulteriore senso di fatica esistenziale. È altresì un lavoro importante e profondo che può essere compreso a partire dall’analogia tra la condizione di Doris e la città di Salzgitter. Una volta individuate le giuste chiavi di lettura si può desiderare di vedere e rivedere questo lavoro, scorgere la ricerca storica fatta in relazione al presente e provare a interpretare ogni aspetto documentato dalla regista.
Regia di Carlo Sironi (Italia, 2016, 20′)
Valparaiso è un cortometraggio italiano sul disagio senza via di fuga di un’immigrata irregolare intrappolata tra un centro di identificazione ed espulsione e una gravidanza indesiderata.
L’impotenza della protagonista è ulteriormente rafforzata dalla scelta narrativa di farle negare il concepimento. Per lei “non è stato nessuno” e “non è successo nulla“. La questione rimane aperta ma resta evidente che il male e l’assenza di libertà pervadono anche la sfera sessuale di Rocio (questo il suo nome).
Dal quarto mese di gravidanza Rocio può usufruire di un permesso di soggiorno temporaneo, perché la legge non permette, in questi casi, la detenzione di una donna incinta.
Da questo momento il cortometraggio subisce rapidi salti temporali, nei quali è tuttavia evidente che la libertà effettiva non sussiste in nessun momento, nemmeno tra quelli non raccontati. La ragazza resta imprigionata in una situazione devastante fino alla nascita del neonato.
Rocio viaggia in autobus con il suo bambino tra le braccia. Il suo sguardo è triste e assente. Una costante “anestetizzazione” da autodifesa sembra caratterizzare la sua mente fino alla fine del film. Il viaggio porta all’ospedale nel quale abbandonerà il proprio figlio.
La protagonista, interpretata dalla bravissima Manuela Martelli, è il vero centro del film, in particolare nella dialettica tra la sua fragilità e la sua aggressività, che emerge sul finale in un momento in cui cerca di riprendersi il bimbo abbandonato. Questi passaggi tra elementi conflittuali (fragilità-aggressività; abbandono-riappropriazione; innocenza-colpevolezza; libertà-necessità) costituiscono l’intero del film. L’ultimo dualismo citato è il più complesso da inquadrare, perché la necessità sembra prevalere sempre sulla libertà della protagonista.
Il gesto di maggiore libertà assume una connotazione negativa e si verifica sul finale quando, nella fase della riappropriazione, Rocio tradisce l’unico individuo gentile che le sia capitato in tutto il contesto raccontato. Un giovane infermiere, spettatore involontario del capovolgimento finale, decide di mettere a rischio se stesso, in modo totalmente altruistico, per permetterle di riabbracciare per l’ultima volta suo figlio. In questo momento la protagonista tenta di riprendersi, con un gesto letteralmente tragico, quel bimbo non desiderato che è diventato tutto il suo universo – e anche qui dobbiamo notare un’altra opposizione. L’esito della sua azione è prevedibilmente drammatico e riporta la donna all’originaria condizione d’impotenza.
La regia è buona e caratterizzata da alcuni primi piani decisamente efficaci. Tutta l’attenzione, anche scenografica, è orientata al personaggio (sono stati evitati elementi superflui, gli ambienti sono piuttosto spogli). Le finalità narrative vengono centrate ed espresse adeguatamente. Mentre per quanto riguarda la fotografia è apprezzabile la scelta di utilizzare luci fredde, decisamente appropriate alla vicenda raccontata.
LUNGOMETRAGGI:
 RECENSIONE – IL RESPIRE ENCORE
RECENSIONE – IL RESPIRE ENCORE
Regia di Anca Hirte
Genere: Documentario (Francia, 2016, 89′)
Scrivere la recensione di un film come Il respire encore può richiedere di dividere l’analisi in due parti, la prima legata alle intenzioni alla base del lungometraggio, la seconda riguardante la sua effettiva realizzazione.
Questo perché le premesse sono decisamente audaci e geniali, almeno quanto rischiose. Capire bene le implicazioni dietro all’idea di questo progetto è importante per comprendere pienamente il valore della realizzazione finale. E queste implicazioni sono molteplici. Detto banalmente, questo è un film su un pugile con elementi musical.
Il musical nasce ovviamente in teatro, ma l’origine della sua versione cinematografica va ricercata in un periodo di transizione, nel quale le esigenze dell’entertainment americano si incontrarono con la definitiva affermazione del sonoro e il conseguente cambiamento tecnologico.
È un genere complesso, richiede un preciso lavoro sintattico e sincronico, ha una storia enorme con un’autonomia e una diffusione paragonabili a quelle del genere western. Fare un musical è rischioso e, dopo il suo declino, gli ottimi tentativi di recuperare questo genere cinematografico (mi riferisco a quelli dalla seconda metà degli anni 90 in poi) sono stati percepiti come decisamente coraggiosi, in quanto da molte persone era percepito come qualcosa di demodè. Con molta fatica è riuscito a riappropriarsi del riconoscimento che gli spetta.
Il pugilato è uno sport ben adattabile al grande schermo e tuttavia i film su questo sport sono fortemente esposti al rischio di cadere nella banalità e nel patetismo. Nonostante ciò sono state fatte moltissime opere cinematografiche sulla boxe – e tanti sono lavori straordinari – e ciò rappresenta un’ulteriore ragione per pensare che oggi i pericoli nascosti nella scelta di raccontare la storia di un pugile siano accentuati.
Insomma nel nostro presente fare musical o fare film sul pugilato è ancora più difficile rispetto al passato. Se tutto ciò appare problematico bisogna ora pensare che il respire encore mescola il musical e la boxe.
Il punto è che sorprendentemente ci riesce benissimo. Il risultato finale è un vero e proprio capolavoro: è originale, spontaneo, emozionante, significativo, sintatticamente riuscito, la musica è perfettamente adatta e ben sincronizzata rispetto a ciò che vediamo.
E se questo non è sufficiente, aggiungiamo che non si tratta di un prodotto costruito ad hoc, bensì di un documentario. Tantissimi elementi apparentemente eterogenei si fondono in questo lungometraggio in cui tutto sembra perfettamente al proprio posto.
Ogni cosa è curata nei minimi dettagli, dalle immagini (alcune veramente belle) alle parti musicali.
Karim Chakim è talmente intenso da portare chiunque non lo conosca a chiedersi se si tratti di un grande attore che interpreta un pugile o di un pugile con un’enorme espressività (è la seconda).
Il respire encore va oltre in tutti i sensi, supera i generi, supera i tempi, supera le possibilità. Si tratta di un grandissimo film.
 RECENSIONE – LA FILLE DU PATRON
RECENSIONE – LA FILLE DU PATRON
Regia di Olivier Loustau
Genere: Fiction (Francia, 2015, 98′)
La fille du patron, nel mettere insieme la complessa semplicità dei rapporti umani, il racconto delle difficoltà lavorative presenti sia per i lavoratori che per le fabbriche e l’importanza del “gioco di squadra”, rende omaggio alla classe operaia e a tutto il suo contesto sociale e industriale.
È bello pensare questo film come a un lungometraggio sull’opporsi alla fine. Può finire l’amore, il matrimonio, il lavoro, il successo. Ma contro la fine è possibile lottare, allontanandola o ridimensionandola per trovare un continuo in altro.
Nel film molti cambiamenti sono mossi dalla storia d’amore tra Vidal, caporeparto della fabbrica tessile francese di cui si raccontano le difficoltà e Alix, la “figlia del capo”, una giovane e promettente professionista che sta svolgendo all’interno dell’industria una ricerca di ergonomia.
Nonostante le tematiche proposte siano piuttosto impegnative, i quasi 100 minuti di La fille du patron scorrono rapidamente. Nella prima metà del film possono sorgere delle perplessità sui fili conduttori di alcune scene chiave (forse un po’ troppo ripetitive nel complesso), ma si comprende bene ogni cosa nella seconda metà. In particolare si chiarifica nel finale il senso dell’aver introdotto all’interno della storia il campionato di rugby tra lavoratori. Lo sport, in questo caso, oltre a dare sostegno alla narrazione (il festeggiamento di una vittoria importante diventa l’occasione per accendere la passione tra i due protagonisti, si creano tensioni avvincenti e aspettative tra giocatori-lavoratori e inoltre amplia le possibili interazioni tra personaggi) permette in chiave alternativa di mostrare l’orgoglio, il riscatto sociale, il successo ma anche il fallimento.
Significativamente dunque, la lotta – sul campo della società, così come su quello da rugby – presenta un valore in sé, a prescindere dal risultato.
Il film riesce bene nei suoi intenti – forse troppi, ma riesce a trovare un equilibrio apprezzabile. La storia d’amore tra l’operaio e la figlia dell’imprenditore è bella, credibile e riesce inoltre a combinare i sentimenti più delicati con la trasgressività.
Tecnicamente La fille du patron è un lungometraggio ben girato ed è assolutamente degno di elogio il triplo lavoro svolto da Olivier Loustau, che è stato attore protagonista, regista e co-sceneggiatore. Tutti questi compiti sono stati portati a termine egregiamente e il risultato finale è un ottimo film.
Articoli precedenti:
CFF – DAY0: recensione all’anteprima dell’8 ottobre
CFF – DAY1: le interviste ai protagonisti e la recensione di After Spring
Articoli successivi:
CFF – Day3: le recensioni dei film in concorso
CFF – DAY4/5: le recensioni dei film in concorso e le premiazioni