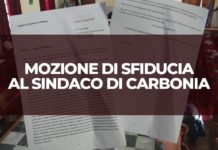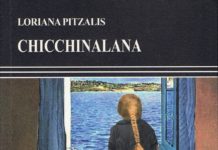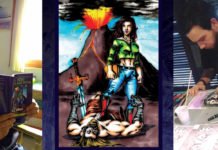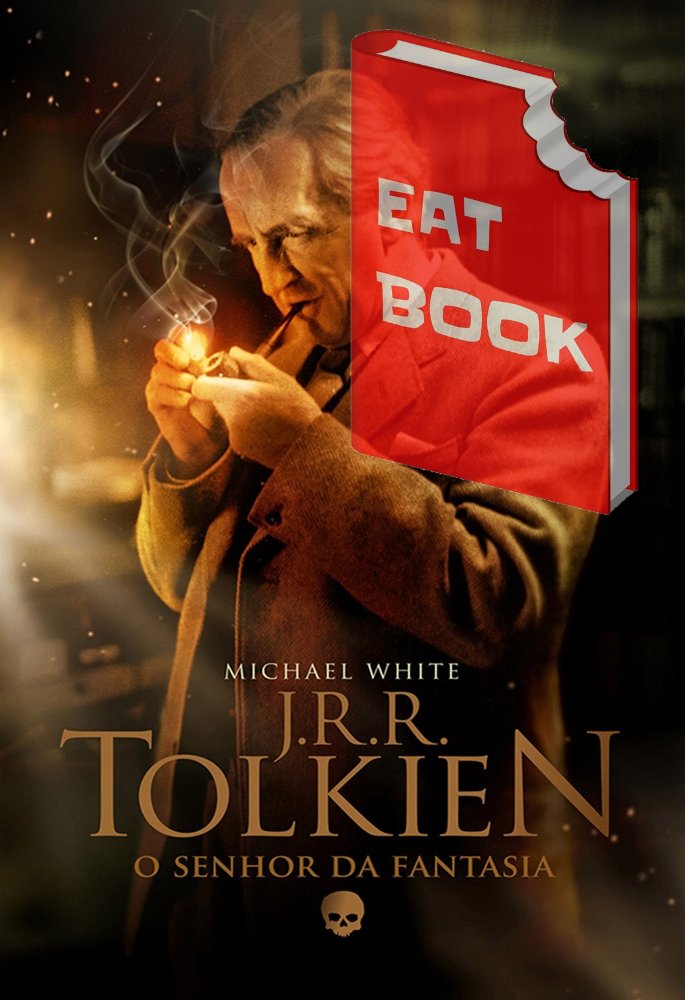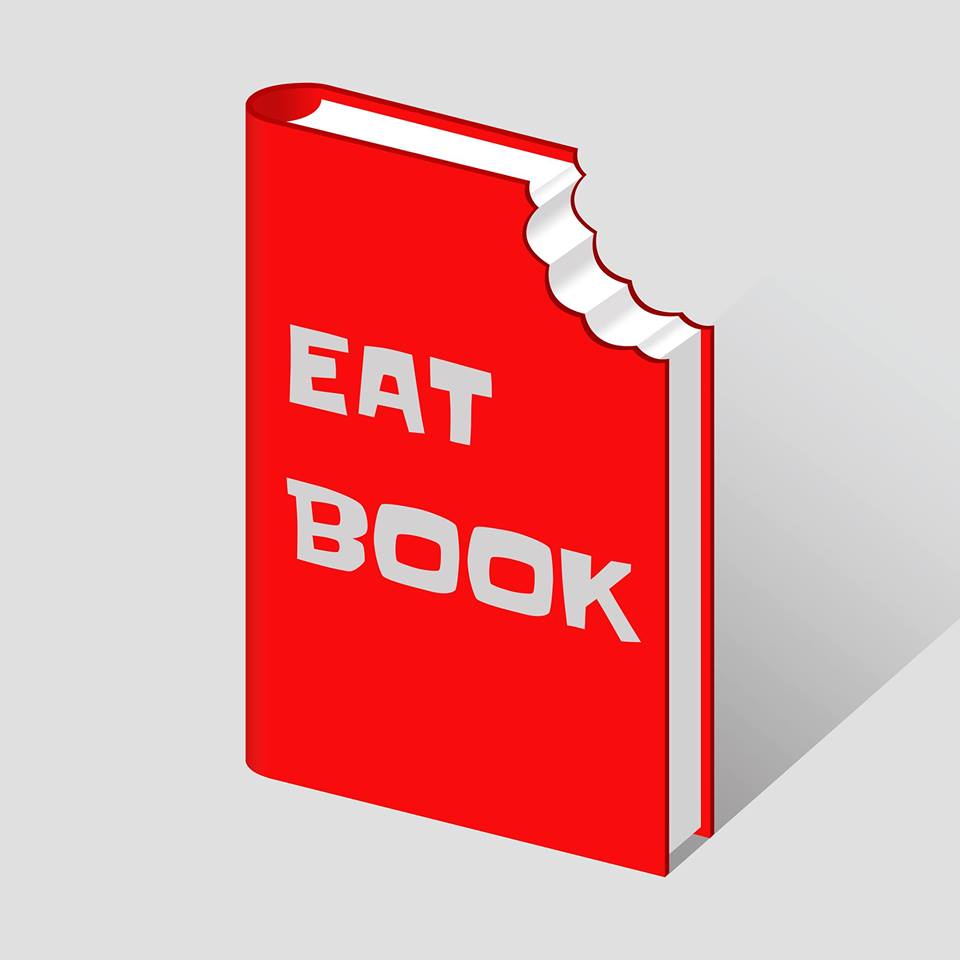Recensione
Regia di Steph Ching e Ellen Martinez
Genere: Documentario (Stati Uniti, 2016, 101′)
After Spring è il frutto dell’esordio al lungometraggio di Steph Ching e Ellen Martinez, due registe diplomate alla New York University. È ambientato a Zaatari, in Giordania, il più grande campo profughi per rifugiati siriani al mondo e racconta la storia di alcune famiglie fuggite dalla Siria, due in particolare, e di alcuni operatori umanitari.
Il film inizia con una breve sintesi del dramma siriano. Nel marzo del 2011 in Siria tantissime persone, stremate dal regime, mettono in atto una protesta pacifica. Alcuni forse l’avevano ipotizzato, per altri risultò totalmente inaspettato, ma la folla venne attaccata, inizialmente con i proiettili per poi passare ai missili. In breve diventò una tomba.
Nel corso del lungometraggio vengono raccontati esplicitamente alcuni episodi drammatici, ma altri ancora – la maggior parte – sono intuibili osservando direttamente nelle persone le conseguenze delle atrocità vissute. In ogni caso, a partire da queste vicende, i siriani hanno iniziato a lasciare il proprio paese. Occorre prestare attenzione all’elaborazione di questo fatto, poiché i profughi, almeno quelli documentari nel film, amano la Siria. Sono arrivati al limite prima di abbandonarla. E restano in fremente attesa anche solo di un minimo abbassamento della soglia di pericolosità e insopportabilità, per poter tornare a casa.
Il campo Zaatari ospita ormai oltre 80.000 rifugiati (dato del 26 marzo 2015 presente su wikipedia en) e sta diventando una sorta di città fatta di tende e roulottes. Anche qui, come in altri luoghi, la fuga disperata ha avuto alla base una forte voglia di vivere, che nel campo ha trovato espressione, praticamente da subito, nel lavoro. Sono state aperte botteghe, pizzerie e ristoranti. Si possono inoltre trovare servizi di ogni genere e tra i bambini si è diffuso il taekwondo, grazie a un maestro-volontario pieno di passione e voglia di guidare positivamente l’energia dei giovani rifugiati. Insomma, il futuro della Siria va costruito nel presente. E il presente è all’interno del campo Zaatari. Qui possiamo vedere persone distrutte a livello psicologico e fisico che tuttavia sorridono, piene di vita.
Nel buon documentario di Steph Ching e Ellen Martinez possiamo trovare anche una risposta concreta a un pregiudizio tipicamente italiano, quello dei “migranti con lo smartphone”.
Già da qualche anno, smartphone totalmente superati nei paesi più ricchi, possono risultare ancora perfettamente funzionali. Questi telefoni possono essere procurati anche gratuitamente. E i rifugiati letteralmente desiderano lo smartphone con internet, perché questo è per loro un mezzo fondamentale per restare aggiornati sulla situazione della Siria, in modo da poterci tornare. Di fatto queste sono persone che per l’assistenza alimentare non ricevono più di 1 euro al giorno. E nonostante ciò è assolutamente normale che abbiano lo smartphone.
Tecnicamente il documentario è girato egregiamente. Nonostante sia un lungometraggio “opera prima”, anche il montaggio riesce a far seguire perfettamente le storie di tutti i personaggi coinvolti, in modo chiaro e scorrevole.
Le criticità riscontrabili nel film sono grossomodo due.
La prima è che la scelta del girato sembra essere stata guidata in modo eccessivo da idee precedenti all’esperienza fatta. In altre parole, si è fatto un lavoro documentario nel tentativo di far emergere un messaggio che a noi è sembrato scelto in precedenza. Le storie raccontate sono genuine e importanti da conoscere, ma forse si poteva dare qualche piccolo spazio in più anche ad altre realtà presenti nel campo. In quel contesto si possono trovare individui e famiglie di ogni genere e non basta accennare al fatto che la notte bisogna fare attenzione perché alcune persone si ubriacano e diventano pericolose. Viene sì raccontata la richiesta d’aiuto da parte di una mamma per il marito che picchia i propri bambini, ma si cerca anche qui di seguire il ridimensionamento al fatto della stessa moglie, che colpevolizza lo stress e non la persona. Sarebbe stato bello insomma avere uno sguardo più ampio sull’intera situazione – operazione che non necessariamente avrebbe compromesso la narrazione delle vicende scelte.
Questo difetto risulta particolarmente accentuato in relazione alla seconda criticità, relativa ad almeno 15 minuti di ridondanza. Alcune scene e alcuni pezzi di girato ci sono sembrati eliminabili o sostituibili. E ogni minuto di troppo, nelle tempistiche cinematografiche, può risultare un’eternità.
Nicola Ruvioli